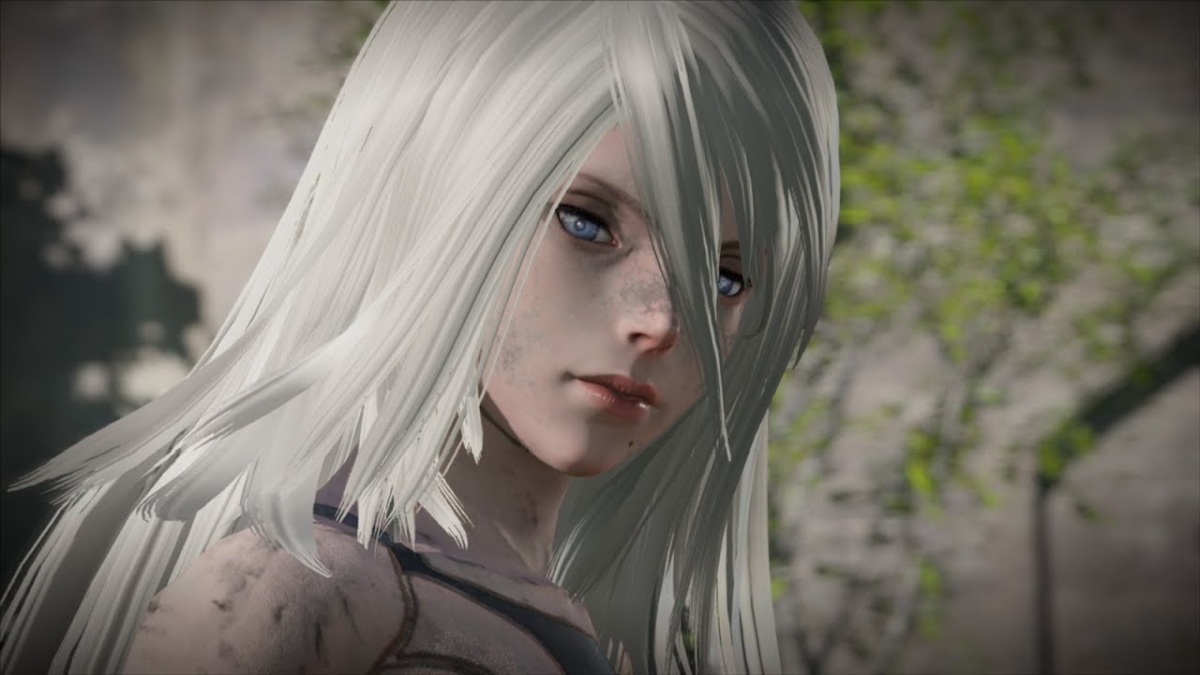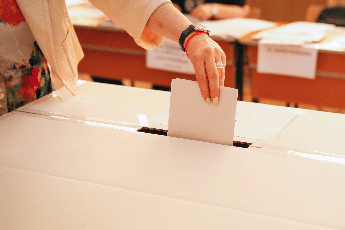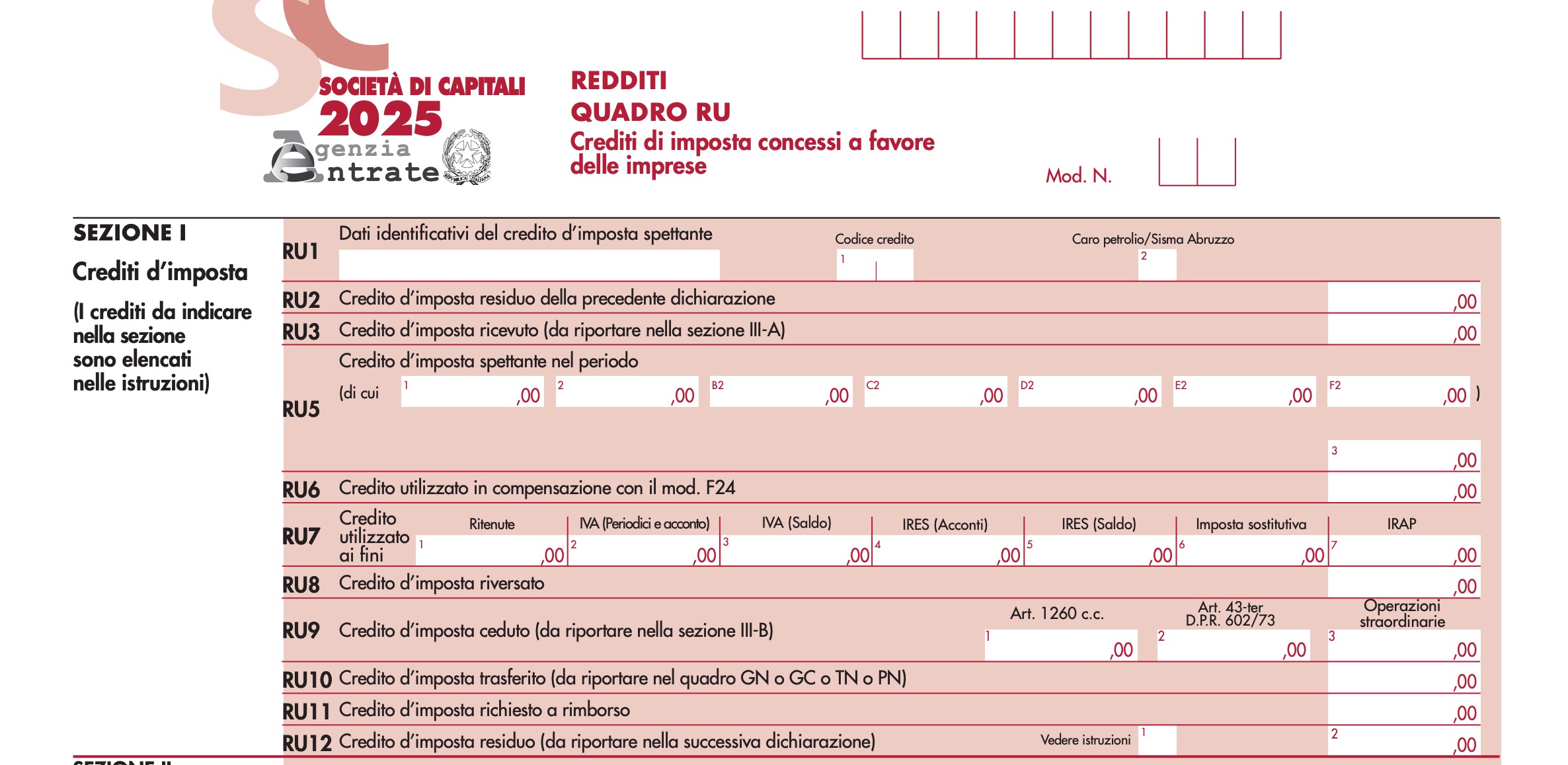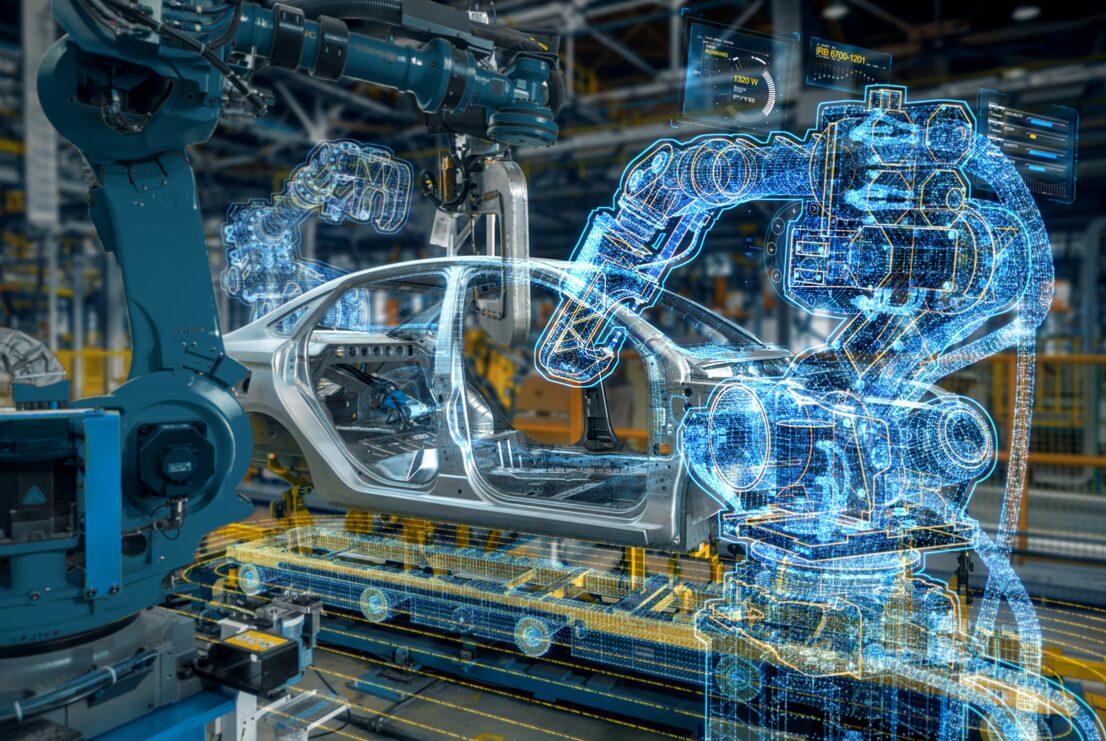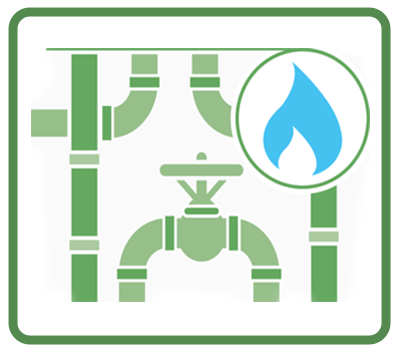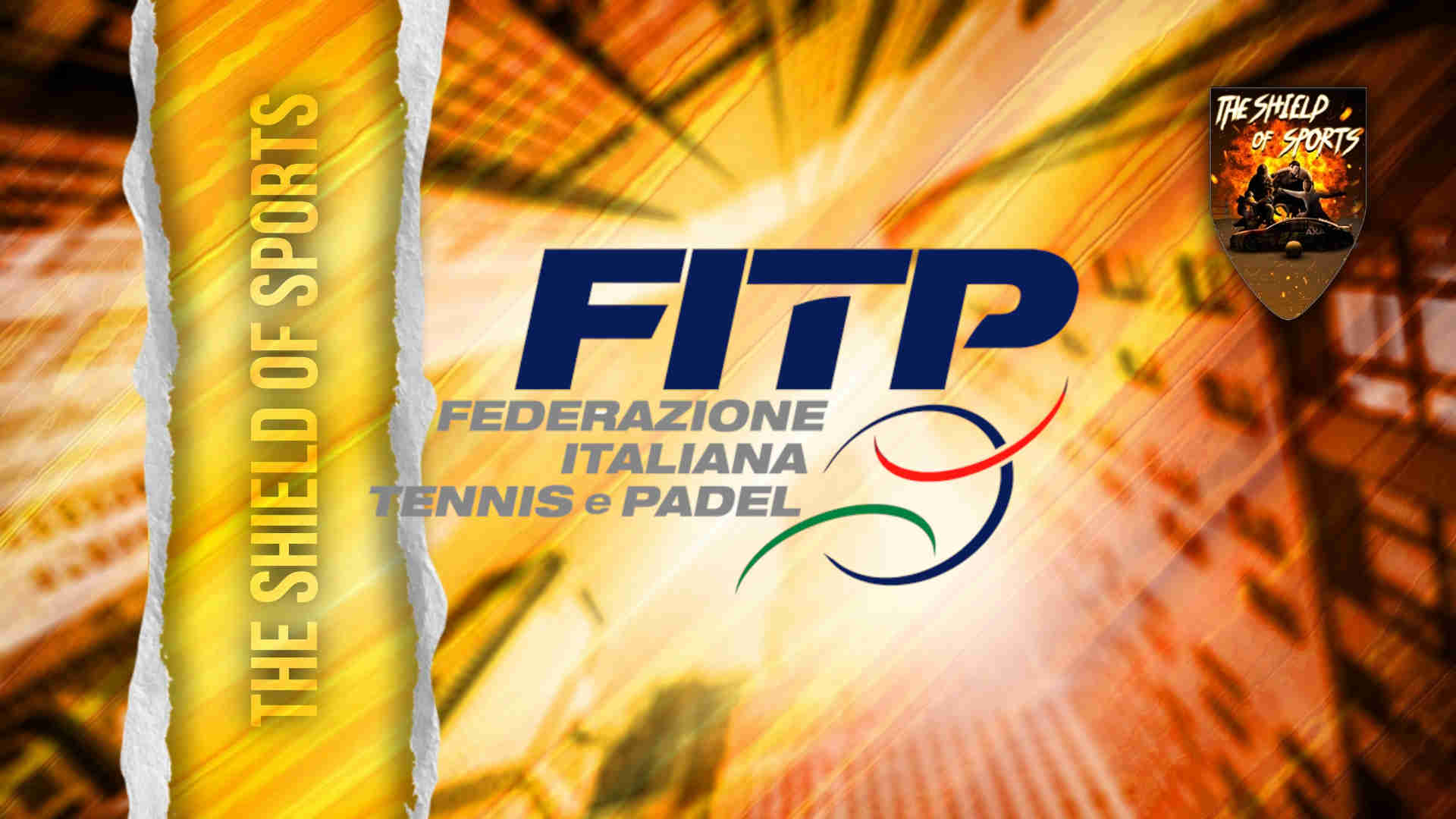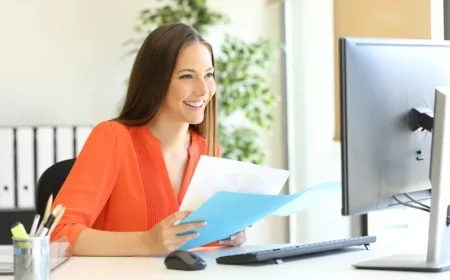La guerra dei dazi mette il fast fashion sotto pressione: scattano gli aumenti

Temporaneamente congelati – tra un turbinio di richieste di negoziati, minacce di ritorsioni e il tonfo delle Borse -, i dazi di Trump spaventano ancora Paesi e industrie, tra cui inevitabilmente anche la moda. In particolare, sono il fast fashion e l’ultra fast fashion a sussultare di fronte allo spettro di un regime tariffario che rischierebbe, al termine dei 90 giorni di stand-by, di sparigliare le carte di un’intera filiera che dei prezzi contenuti e di una supply chain geograficamente strategica ha fatto il proprio marchio di fabbrica. Proprio l’ultra low cost è tra i primi ad aver iniziato a rispondere allo spettro dei dazi aumentando in modo significativo i prezzi dei suoi beni. Secondo quanto riporta Bloomberg, “il prezzo medio dei 100 prodotti principali nella categoria bellezza e salute è aumentato del 51% da giovedì, con diversi articoli che hanno più che raddoppiato il loro prezzo. Per i prodotti per la casa, la cucina e i giocattoli, l’aumento medio è stato di oltre il 30 per cento. Per l’abbigliamento femminile, l’aumento è stato dell’8 per cento”.
“Se i dazi verranno effettivamente reintrodotti – ha spiegato a Pambianconews Claudia Lotti, senior managing director di Fti Consulting – anche il settore del fast fashion ne risentirà, coinvolgendo sia i grandi gruppi occidentali sia quelli asiatici. Le aziende si trovano di fronte a due possibili risposte: aumentare i prezzi per il consumatore finale o riorganizzare la propria supply chain per aggirare i nuovi ostacoli commerciali”.
Due vie che in realtà non si escludono a vicenda e dovrebbero, invece, coesistere. In qualsiasi scenario, ad ogni modo, “i costi tenderanno a salire, almeno nel breve periodo, con una probabile ricaduta sui prezzi finali”, mette in guarda l’analista.
La conferma del trend ascendente che sta già interessando i prezzi del fast fashion arriva innanzitutto dai colossi asiatici, Shein e Temu. I due player della moda – e non solo – a basso costo hanno infatti annunciato come dal 25 aprile, in seguito ai “i recenti cambiamenti di regole e tariffe commerciali globali”, le loro spese operative siano aumentate al punto da giustificare degli “aggiustamenti di prezzo” per la clientela americana.
La Cina rappresenta infatti l’eccezione nel quadro di sospensione dei dazi da parte del presidente americano (ma proprio nei giorni scorsi Trump ha suggerito la possibilità di ridurre sostanzialmente i dati sul Paese asiatico), ma la mossa di Shein e Temu arriva primariamente in risposta all’eliminazione della ‘esenzione de minimis’ sulle spedizioni dalla Cina verso gli Stati Uniti per un valore inferiore agli 800 dollari, manovra che sarà operativa dal prossimo 2 maggio. Una stangata non da poco per i due dragoni, che avevano finora beneficiato di tale escamotage. Piattaforme di e-commerce come Shein e Temu si trovano dunque ad affrontare una tariffa del 120% su molti dei loro prodotti.
E se l’ultra fast fashion asiatico starebbe già pagando pegno, lo scenario non appare confortante neanche per la moda low cost occidentale. È stato H&M, i cui dati relativi al primo trimestre 2025 sono usciti alla fine di marzo, il primo a esprimersi sul tema: per il direttore finanziario Adam Karlsson, il player potrebbe infatti dover aumentare i prezzi negli Usa proprio per mitigare l’impatto delle nuove tariffe.
A preoccupare, però, i vertici della società ci sono però anche i dazi aggiuntivi del 20% sulla Cina – dove si trovano i poli produttivi dell’azienda – e quelli reciproci verso il Bangladesh, questi ultimi per il momento sospesi.
Attualmente, la strada di un ripensamento, geografico e strategico, della propria supply chain appare complessa, anche in funzione dell’incertezza sulla politica americana, con la possibilità che determinate misure economiche vengano in un secondo momento cancellate o fortemente ridimensionate. “I margini di manovra sono limitati – conferma ancora Lotti-. Le competenze produttive, l’accesso alle materie prime e il basso costo del lavoro sono concentrati in specifiche aree. Riorientare la produzione richiede tempo e risorse, e spesso comporta un calo dell’efficienza. Per questo è più probabile che i brand decidano di spostare solo una parte marginale della produzione o che accettino una temporanea compressione dei margini”.
Lavorare sul prezzo, dunque, a discapito del consumatore finale o della propria marginalità in prima battuta, sembra essere la via più facilmente percorribile. Di questo avviso, infatti, sembra essere anche la spagnola Mango, che starebbe “prendendo le misure con i dazi imposti dall’amministrazione Trump sulle importazioni dalla Cina” – aveva affermato il CEO Toni Ruiz in un’intervista congiunta a Reuters e il quotidiano francese Les Echos – riconsiderando la tipologia di offerta proposta oltreoceano senza, per il momento, prevedere impatti sul prezzo finale.
Del resto, il player aveva già pianificato un potenziamento della propria presenza negli Usa, suo quinto mercato, attraverso un upgrade della label verso un posizionamento premium. Si tratta, comunque, di “una strategia ambiziosa – osserva Lotti – soprattutto in un contesto di rallentamento economico e incertezza nei mercati del fashion e del lusso”.
Aggiungendo: “È plausibile che l’azienda possa rivedere il ritmo di espansione o adottare un approccio più selettivo. Il riposizionamento verso una fascia di prezzo più alta richiede coerenza tra comunicazione, pricing e qualità percepita: un processo complesso che richiede tempo”.
Sebbene resti ancora da capire, dunque, come si evolverà la strategia dei dazi messa in atto dagli Usa di Trump, al momento, guardando ai player del fast fashion, è difficile immaginare uno spostamento sensibile nelle tratte produttive del comparto, che sono lunghe, frammentate e geograficamente incentrata proprio su Cina e Sud-est asiatico, per ragioni economiche e politiche.
Anche la società di consulenza Bernstein, in una nota redatta al riguardo, evidenzia come “sebbene l’imminente sofferenza dei dazi doganali diffusi renderà le catene di approvvigionamento globali più costose, gli ingenti costi e le interruzioni richieste per la produzione nearshore su larga scala non valgono ancora la pena di essere implementati su larga scala”.
Menzionato, come unica e “rara eccezione” nel panorama low cost, il caso di Inditex, il cui “intero modello di acquisto e distribuzione è stato progettato fin dall’inizio attorno all’approvvigionamento localizzato”. Ma in generale sono poche le alternative ai sopraccitati Cina e al Sud-est asiatico, per coloro che ricerchino “il giusto livello di competenza e scalabilità, a un costo inferiore, senza incorrere in significativi rischi geopolitici o sociali”.
E la delocalizzazione appare ancora più complessa, sottolinea Lotti di Fti Consulting, per i colossi dell’ex Celeste Impero, la cui struttura è “profondamente integrata e pensata per operare esclusivamente dalla Cina. Ricreare una filiera analoga altrove, specialmente negli Usa, è oggi poco realistico”.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0