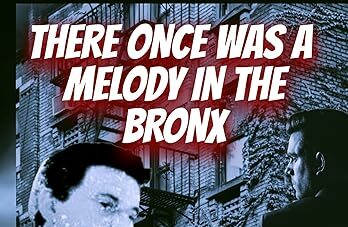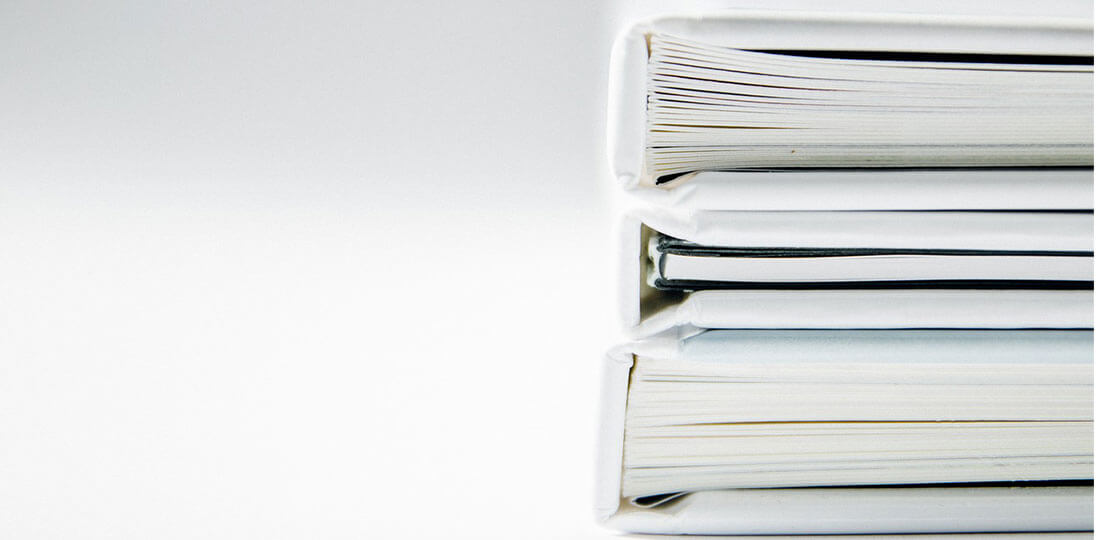L’archiviazione non è una condanna morale: restituiamo laicità alla Giustizia

Negli ultimi anni, il nostro sistema giudiziario ha visto emergere una tendenza preoccupante: quella di travestire le richieste di archiviazione in vere e proprie condanne morali. Questa pratica, puntualmente censurata dalla Corte Costituzionale, solleva interrogativi fondamentali sul ruolo di giudici e pubblici ministeri, chiamati a essere custodi di una giustizia laica, imparziale e priva di filtri ideologici. Purtroppo, la realtà processuale sembra essere soggetta a interpretazioni personali che travalicano la mera applicazione della legge in favore di un’opinione morale che di per sé non ha peso giuridico.
Prendiamo ad esempio la recente richiesta di archiviazione riguardante la vicenda del figlio di Ignazio La Russa. In questo caso, l’archiviazione è stata accompagnata da affermazioni che, pur non configurando illeciti penalmente rilevanti, descrivevano comportamenti ritenuti “disdicevoli” o “immorali”. Qui sorge un primo interrogativo: a cosa serve la giustizia se anziché illuminare il quadro giuridico, si esprime solo giudizi morali? In un mondo ideale, ci aspetteremmo che un giudice si limiti a esprimere un giudizio binario: colpevole o non colpevole. Siamo lontani dalla teocrazia degli ayatollah, ma che talvolta un retrogusto moralista riesca a insinuarsi tra le maglie del nostro ordinamento è, quantomeno, preoccupante.
La storia della giustizia italiana, dal caso Tangentopoli alla saga di Silvio Berlusconi, è costellata di situazioni analoghe. Eppure, non possiamo fare a meno di notare come il rilievo che viene dato alle figure coinvolte – spesso illustri o in vista – possa influenzare non solo l’interpretazione dei fatti, ma anche la percepção collettiva di giustizia. Lorenzo Milani una volta affermò che “l’ingiustizia in un luogo è un pericolo per la giustizia in tutto il mondo”. Oggi, potremmo dire che l’ingiustizia morale è un pericolo per l’equità in tutto il sistema giudiziario. Il personaggio Berlusconi, oggetto di fiumi di inchiostro e di una retorica moralista da parte di molti PM, ha successivamente dimostrato come il ruolo di giudice possa scivolare in un ambito inaccettabile, diventando un’arma di distruzione della reputazione. La stessa cosa accade oggi con il figlio di La Russa, in un triste, ma non nuovo, copione. Ci si può chiedere: l’investigatore della verità, per sua stessa definizione, è autorizzato a muovere valutazioni etiche oltre i confini del reato in sé?
È evidente che il nostro sistema ha bisogno di un ripristino della laicità. La giustizia non deve essere influenzata da dettami morali o da correnti di pensiero, ma deve rimanere un mero strumento di valutazione del comportamento umano in relazione a ciò che è legalmente previsto, a meno che non sia strettamente necessario ai fini dell’accertamento dei fatti penalmente rilevanti. Si chiama continenza, ed è un principio prima logico e poi giuridico. Voltaire inorridirebbe a leggere certi atti giudiziari, che recano il rischio di rincorrere certo viscido senso popolare, quello che il nazismo chiamava lo “spirito del popolo”. Uno Stato laico deve crescere nella consapevolezza che l’unico ‘sputtanamento‘ accettabile è quello delle pratiche che intaccano il principio di legalità, non delle persone, soprattutto quando queste ultime non commettono reati.
In conclusione, risuona l’appello a una giustizia che rimanga ancorata a principi razionali e inappellabili, senza cedimenti a derive moralistiche e sentimentali. La giustizia non ha bisogno di affermazioni che possano ledere la dignità di un individuo; ha solo bisogno di esistere, con la sua natura binaria, a prescindere dalle sfumature morali che ciascuno di noi può percepire. Se non torniamo a questa essenza, corriamo il rischio di trasformare i tribunali in arene di caccia al colpevole morale, piuttosto che in luoghi di verità e giustizia. E non possiamo permetterlo.
Qual è la tua reazione?
 Mi piace
0
Mi piace
0
 Antipatico
0
Antipatico
0
 Lo amo
0
Lo amo
0
 Comico
0
Comico
0
 Furioso
0
Furioso
0
 Triste
0
Triste
0
 Wow
0
Wow
0


























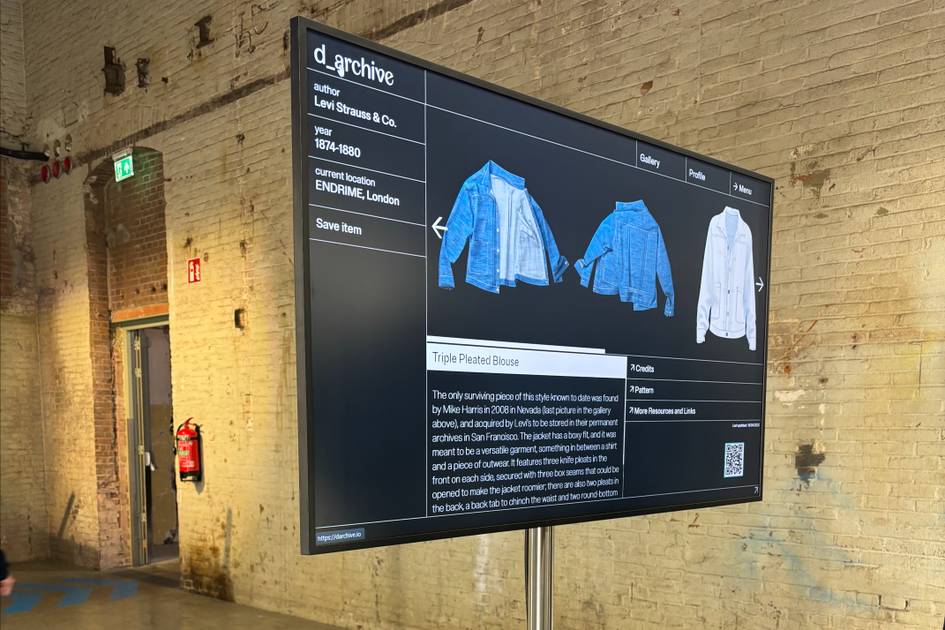







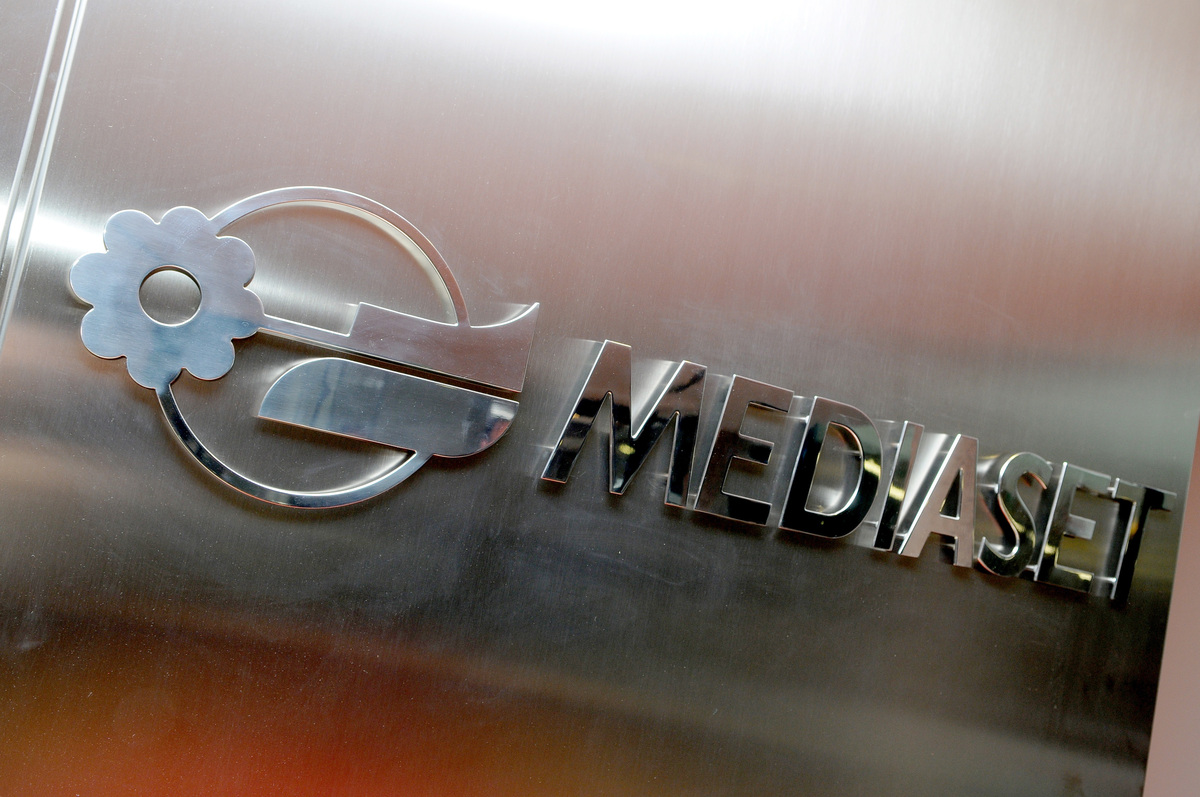












































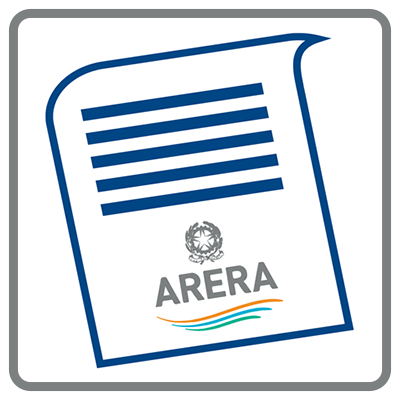




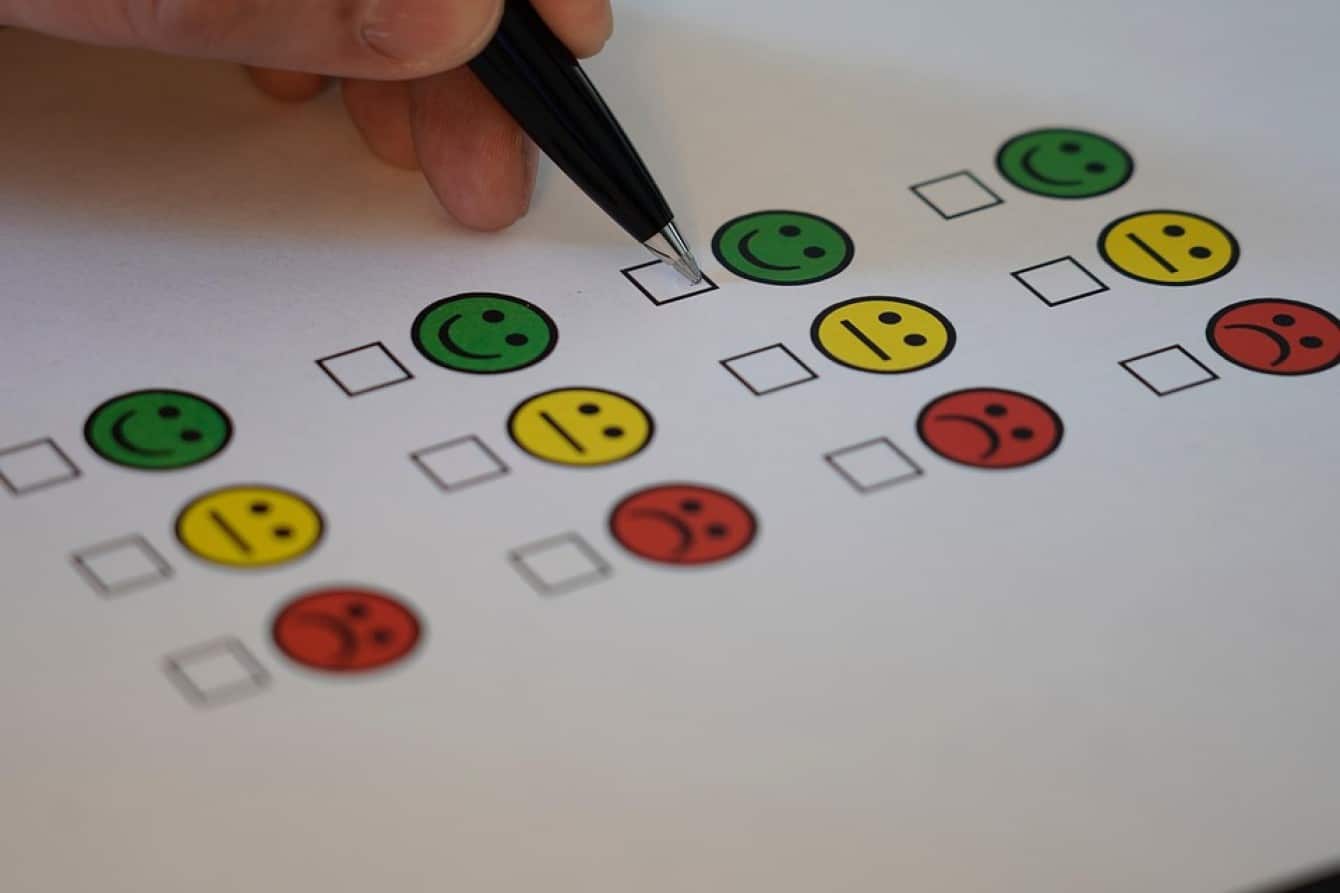









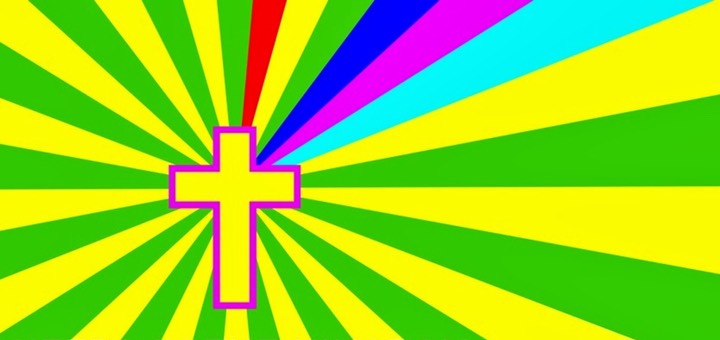

























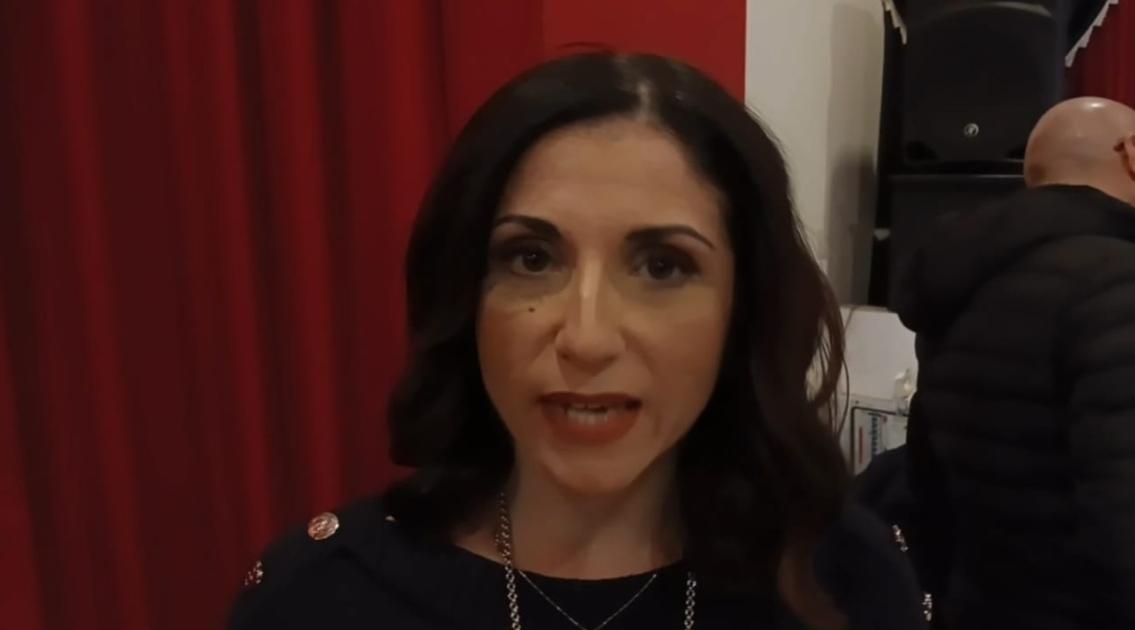















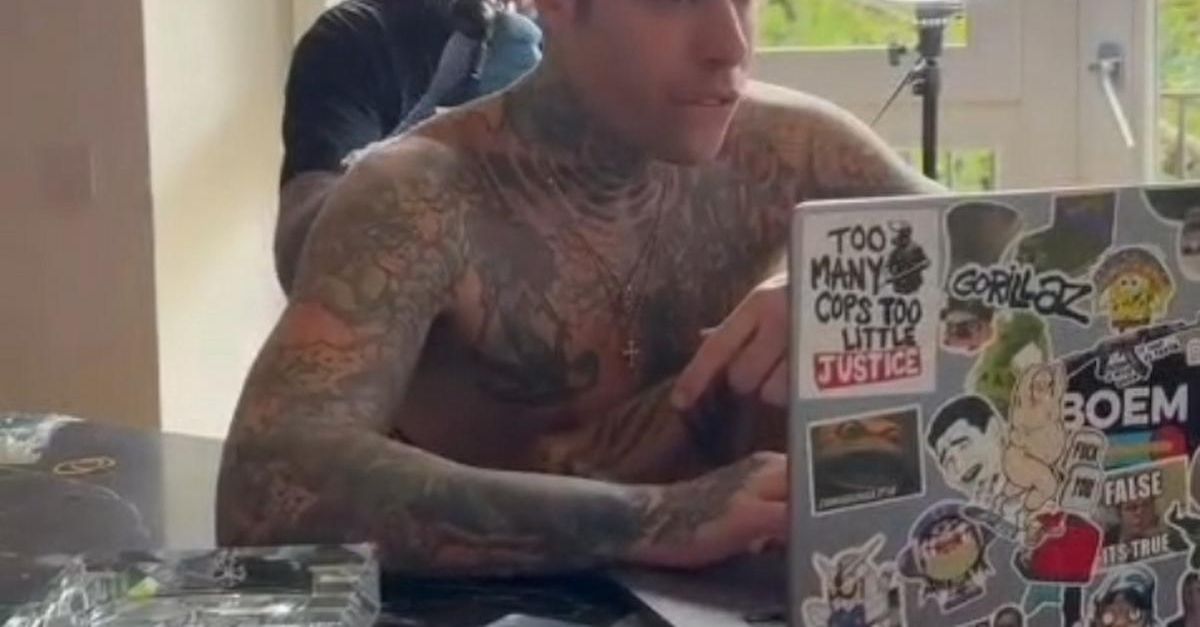




































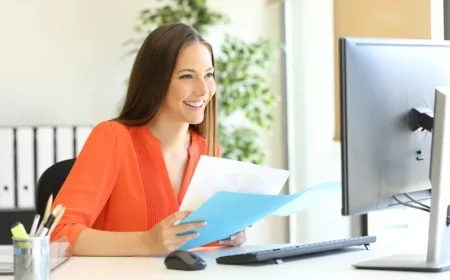












-1744897245488.png--hpv_e_salute_della_donna__l_importanza_del_vaccino__screening_e_educazione_sessuale.png?1744897245622#)





-1732628336827.png--giovane_aggredito_da_tre_buttafuori_a_urbino_ma_dopo_un_mese_e_mezzo_nessuno_ha_ancora_sentito_la_vittima.png?1732628340016#)