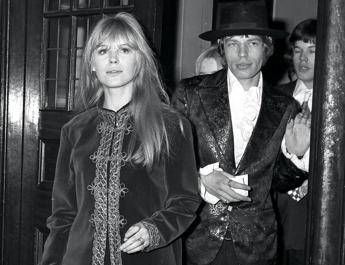Porzûs, la pagina nera della Resistenza
AGI - Partigiani messi al muro, immagine purtroppo consueta della guerra civile nel periodo 1943-1945 che insanguinò l'Italia durante la guerra di liberazione. Ma in quel febbraio 1945 dalla parte del plotone d'esecuzione c'erano altri partigiani: fazzoletti rossi contro fazzoletti verdi, comunisti contro cattolici, garibaldini contro osovani. Una delle pagine più laceranti della contrapposizione ideologica è stata scandita dalle raffiche di mitra che falciarono in più riprese i patrioti delle formazioni autonome: una delle pagine più nere della Resistenza. L'ordine arbitrario di passare con Tito che aveva mire sull'Italia Il padovano Mario Toffanin aveva 33 anni, da dodici militava nel Partito comunista e invece di imbracciare le armi per Mussolini nel 1940 si era sottratto alla chiamata di leva riparando in Jugoslavia, dove le avrebbe prese per combattere con i partigiani. Dopo la resa dell'Italia e allo sfascio che ne era seguito, era entrato nei Gruppi di azione patriottica, i G

AGI - Partigiani messi al muro, immagine purtroppo consueta della guerra civile nel periodo 1943-1945 che insanguinò l'Italia durante la guerra di liberazione. Ma in quel febbraio 1945 dalla parte del plotone d'esecuzione c'erano altri partigiani: fazzoletti rossi contro fazzoletti verdi, comunisti contro cattolici, garibaldini contro osovani. Una delle pagine più laceranti della contrapposizione ideologica è stata scandita dalle raffiche di mitra che falciarono in più riprese i patrioti delle formazioni autonome: una delle pagine più nere della Resistenza.
L'ordine arbitrario di passare con Tito che aveva mire sull'Italia
Il padovano Mario Toffanin aveva 33 anni, da dodici militava nel Partito comunista e invece di imbracciare le armi per Mussolini nel 1940 si era sottratto alla chiamata di leva riparando in Jugoslavia, dove le avrebbe prese per combattere con i partigiani. Dopo la resa dell'Italia e allo sfascio che ne era seguito, era entrato nei Gruppi di azione patriottica, i Gap di ispirazione comunista derivati dalle Brigate Garibaldi.
Toffanin aveva assunto il nome di battaglia di Giacca. Agli inizi del 1945 era a Udine a capo di un battaglione di un centinaio di partigiani che il 7 febbraio si mise in marcia verso la malga di Porzûs, nel Friuli orientale annesso al Reich come Ozak (Operationszone Adriatisches Küstenland), zona della Brigate Osoppo, formazione autonoma di ex militari, cattolici, monarchici, socialisti e laici.
Tranne la volontà di sconfiggere il nazifascismo, tutto li divideva. Il solco si era accentuato da quando, alla fine del 1944, il Pci aveva ordinato alle formazioni partigiane di oltrepassare l'Isonzo per mettersi alle dipendenze del IX Corpus sloveno della IV Armata dell'Esercito popolare della Jugoslavia, forte di oltre 50.000 uomini, al comando di Tito. Il partito non solo si era arrogato un potere che spettava al CLN ma soprattutto intendeva supportare gli jugoslavi nelle aperte mire sull'Istria, su Gorizia, Pola e in particolare Trieste. I “verdi” non si erano pertanto uniti ai “rossi”. In quella terra di confine già dopo l'8 settembre 1943 si era scatenata la prima ondata di infoibamenti, che aveva mostrato il volto feroce della vendetta e il carattere anti-italiano della guerra partigiana slava.
Raffiche di mitra e l'accusa di tradimento
Il gruppo di Toffanin aveva quindi raggiunto il comando del Gruppo brigate est della Osoppo guidato dal capitano Francesco De Gregori, col nome di battaglia Bolla. La scusa era quella di vagliare la posizione di una ragazza ritenuta una spia dei tedeschi, Elda Turchetti, e di chiarire l'atteggiamento dei “verdi” nella conduzione della guerra di liberazione, a partire dal rifiuto di combattere nel IX Corpus e a finire con i rapporti con i militi repubblichini della X Mas e del reggimento alpino “Tagliamento” decisi a preservare a ogni costo il confine orientale dalle mire di Tito.
La Turchetti era già stata processata dagli osovani il I febbraio e riconosciuta innocente.
Non ci fu neppure il tempo di intavolare una discussione: De Gregori, il commissario politico del Partito d'Azione Gastone Valente (Enea), il giovane Giovanni Comin (Gruaro, salito a Porzûs per arruolarsi) e la stessa Turchetti, vennero subito freddati a colpi di mitra, mentre Aldo Bricco, pur ferito, era riuscito a dileguarsi nella macchia. Altri sedici osovani, tra cui Guido Pasolini (Ermes) vennero subito disarmati e presi prigionieri: il loro destino sarebbe stato deciso nelle ore seguenti. Solo due accetteranno di entrare nelle fila garibaldine, mentre gli altri quattordici saranno passati per le armi.
Il processo ai responsabili e ai mandanti del crimine
Nel dopoguerra l'eccidio di Porzûs sarà occultato nelle pieghe della storia, per imbarazzo e opportunismo politico. I responsabili della strage consumata tra il 7 e il 18 febbraio 1945 vennero denunciati il 23 giugno 1945 dai comandanti Candido Grassi (Verdi, socialista) e Alfredo Barzanti (Paolo, democristiano) a nome del Comando gruppo divisioni Osoppo Friuli. Due giorni prima a Cividale del Friuli erano state celebrate le esequie delle vittime, i cui corpi interrati a Bosco Romagno erano stati rivenuti dai parenti.
Il comandante della Brigata Garibaldi Friuli e il commissario politico avevano rifiutato di appoggiare la denuncia. Trascorreranno anni prima dell'apertura del processo, e solo a seguito di una denuncia pubblica documentale. Dopo un rimpallo di competenze, il dibattimento con 45 imputati iniziò a Brescia nel 1950, subito integrato con nuove denunce, ulteriori cambi di foro e spostamento a Lucca.
Pesanti le accuse: omicidio aggravato e continuato, tradimento, sequestro di persona, rapina aggravata, plagio, attentato all'integrità dello Stato. Pesanti anche le presenze nelle fila dell'accusa e della difesa, con importanti esponenti politici in toga che riproducevano la contrapposizione di allora: Umberto Terracini, Fausto Gullo, Leonetto Amadei, Giuseppe Ferrandi, Luigi Gasparotto, Albino Donati, Giovanni Carignani, Valdo Fusi. Come testimoni vennero chiamati il generale Raffaele Cadorna, comandante del Corpo volontari della libertà, ed Enrico Mattei.
La latitanza degli esecutori della strage e il ruolo del Pci
Nel frattempo il Partito comunista aveva già messo al riparo Mario Toffanin e altri 17 imputati, facendoli riparare in Jugoslavia e in Cecoslovacchia. Alla sbarra ne rimanevano 33. La sentenza di primo grado, emessa il 6 aprile 1952, inflisse l'ergastolo a Toffanin, Vittorio Juri e Alfio Tambosso (poi commutato a 30 anni di reclusione), due condanne a 30 anni e pene minori, con dieci assoluzioni.
Tutti assolti dalle accuse di tradimento e attentato all'integrità dello Stato. Palmiro Togliatti inviò un telegram
ma con «la solidarietà affettuosa del partito, che dalle ingiuste condanne è uscito più grande e più forte per il consenso dei cittadini animati da spirito di democrazia e di amor di patria». L'appello voluto da ambedue le controparti, a Firenze nel 1954 confermò l'esclusione del tradimento e attentato all'integrità dello Stato, e le pene inflitte per i reati principali inasprendo quelle per i reati di sequestro di persona e saccheggio. Ma, a seguito di varie amnistie e condoni, nessuno degli imputati presenti finì in carcere.
Nel 1957 la Cassazione confermò le sentenze divenute quindi definitive e dispose un nuovo processo, che si tenne a Perugia nel 1959, per i reati di tradimento e attentato contro l'integrità dello Stato per tutti gli imputati più importanti. Ma nel frattempo fu promulgato un decreto presidenziale sui reati politici e pertanto in fase istruttoria fu eccepita l'estinzione del reato per sopraggiunta amnistia per tutti gli imputati, sancita con sentenza dell'11 marzo 1960.
La grazia e la pensione a Toffanin decorato come eroe in Jugoslavia
Mario Toffanin, decorato dalla Jugoslavia, andò a vivere in Cecoslovacchia e poi tornò in Slovenia nel 1991. Nel 1978 il presidente della Repubblica Sandro Partini gli aveva concesso la grazia. Continuò a percepire la pensione Inps di ex combattente fino alla sua morte, avvenuta nel 1999. Le sue vittime Francesco De Gregori e Guido Pasolini erano rispettivamente lo zio del cantautore, che fu battezzato nel 1951 col suo nome, e il fratello del poeta e regista Pierpaolo, che testimoniò al processo.
Qual è la vostra reazione?